“Le città invisibili di Italo Calvino, presso la Biblioteca civica di Pordenone, un corpus di opere dell’architetto e illustratore Matteo Menotto (1983). Raffinate, colte, ricche di suggestioni letterarie e di elementi architettonici scomposti.
Le città di Matteo Menotto si articolano tra immaginari percorsi figurativi e riletture digitali della dimensione temporale e formale. Il fascino di simmetrie iperboliche che si inerpicano su cristalline, inattese, silhouette grafiche.
Elvira D’Angelo: Potrebbe raccontarci come nasce una sua opera. Ovvero la sua genesi partendo dalla fase progettuale sino a quella operativa.

Matteo Menotto, “Nicchia”, pittura digitale e acquerello su canvas.
Matteo Menotto: La genesi di un’opera per me è un processo duraturo nel tempo, che richiede una progressiva analisi e stratificazione di sensazioni e concetti che desidero esprimere. Lavorando in digitale, i pensieri stessi da cui parto sono immagini che poi compongo, assemblo, taglio e ribalto nel tentativo di relazionare in un quadro più ampio. La sfida, forse, e sicuramente lo stimolo del mio lavoro sta proprio nel tentativo di creare un mondo nuovo partendo da elementi preesistenti, che vengono astratti dal loro significato originale e rivisti all’interno di una nuova struttura. Per questo molto spesso adopero le silhouette: sono affascinato dalla forza evocativa che le forme possono avere e al tempo stesso dal potere immaginifico che se ne trae nel vederle rinnovate in uno spazio in cui sta alla sensibilità di chi guarda i contorni figurane i contenuti.
Ho spesso riflettuto su alcuni passaggi di Focillon che in Vita delle forme definisce come ogni attività, nella misura in cui prende forma inserendosi nello spazio e nel tempo, divenga una «forma artistica» che «esercita una specie di calamitazione sui diversi significati o piuttosto si presenta come una specie di stampo in cui l’uomo versa di volta in volta materie molto dissimili che si sottomettono alla curva che le preme, acquistando così un significato inatteso»[i].
Sono pertanto rimasto molto affascinato da come si possa considerare che le forme «obbediscono a regole loro proprie, insite in loro o, se si vuole, nelle regioni dello spirito che sono la loro sede e il loro centro»[ii] e soprattutto da questa idea di “vita delle forme”, da come nel suo storico incessante rinnovarsi, «non si elabora secondo dati fissi, costantemente e universalmente intellegibili, ma genera diverse geometrie all’interno della geometria stessa»[iii].
Ecco, così credo di aver tentato, anche inconsciamente, di relazionare la mia ricerca visiva alla forza evocativa della forma attraverso il potere dell’immagine e della composizione di forme in immagini.
Elvira D’Angelo: Nel processo creativo qual è il ruolo svolto dalle nuove tecnologie, in particolare quali applicazioni e quali procedure utilizza per creare le sue città invisibili?
Matteo Menotto: Personalmente reputo che ogni forma d’arte sia immagine del tempo in cui viene concepita e parimenti ciascuna opera è figlia dei mezzi espressivi di un tempo. Al giorno d’oggi è impossibile non confrontarsi con il mondo digitale, con il linguaggio mediatico e con le influenze visive che provengono dal forte impatto che la tecnologia ha sulla nostra quotidianità. Personalmente ho deciso di farne anche uno strumento espressivo, adoperando proprio la media-art come strumento operativo. A livello di programmi mi servo molto della suite Adobe (Illustrator e Photoshop principalmente) stampando principalmente su canvas. Di fatto tento di coniugare questa espressività contemporanea con una tecnica a me molto cara e sicuramente più radicata nel tempo, l’acquerello. Credo che il contrasto tra la fluidità del colore steso a mano e la perfezione compositiva di quanto viene creato a computer possa in qualche modo offrire un frammento dello spirito del nostro tempo senza dimenticarsi del valore dell’artigianalità che sta dietro a ciascuna opera.

Matteo Menotto, “Ottavia”, 2011. Pittura digitale e acquerello su canvas, 70 x 50 cm.
Non vorrei essere frainteso in questo mio desiderio di contemporaneità dato che in molti dei miei riferimenti visivi (dichiarati o sottesi) cerco di essere trasversale rispetto ai periodo storici. Anzi, spesso il fascino maggiore lo provo nel guardare alle opere più distanti dal presente. In generale ciò che maggiormente cerco, soprattutto nei riferimenti e nelle ispirazioni, sta in quel senso di totalità dell’arte, nel potere di un messaggio che trascende il tempo. Forse è proprio la consapevolezza del persistere del valore e della forza comunicativa di alcune opere nel tempo, che può permetterci di lavorare e creare nel nostro tempo ma con uno slancio più universale. Ciò deriva dal fatto che credo fortemente nell’universalità della natura umana, nel senso che alcuni tratti caratteriali, così come alcuni sentimenti e modi di percepire il mondo, ritornano nel tempo al di là delle differenze tra le epoche. Ciò che muta ovviamente sono le contingenze e i mezzi che le circostanze del nostro momento storico ci offrono.
Da piccolo sognavo attorno all’idea dei varchi temporali, che tra i miei ricordi di infanzia sono un tema particolarmente forte in alcuni racconti o film animati di qualità nemmeno troppo elevata. Eppure trovavo terribilmente affascinante la possibilità di potersi relazionare con una umanità uguale a noi nei suoi caratteri di genere ma di fatto totalmente diversa per le distinte capacità di comprendere i fenomeni che un differente stadio evolutivo relativo al progresso (tecnologico, scientifico etc.) ne aveva prodotto.
Ma forse, al di là di divagazioni puramente introspettive, un pensiero che più universalmente descrive il nostro sentire nello spazio e nel tempo sta in quelle righe in cui Bernardo di Chartres diceva che tutti siamo, rispetto a coloro che ci hanno preceduto, «come nani sulle spalle dei giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l’altezza del nostro corpo per l’acutezza della nostra vista, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti »[iv].
Elvira D’Angelo: Qual è il loro peso in relazione all’aspetto creativo?
Matteo Menotto: Sicuramente la consapevolezza e la padronanza del mezzo tecnologico ampliano lo spettro delle soluzioni che ciascun artista può presentare, così come nelle scuole di pittura Rinascimentale la capacità di mescolare i pigmenti cromatici permetteva di dipingere cieli di azzurri più intensi.
Tuttavia, posto il fatto che al momento attuale viviamo in un tempo in cui a livello visivo grazie alle tecnologie si può creare tutto ciò che sino a pochi decenni fa era impensabile, reputo che al di là delle potenzialità del mezzo in sé vi stiano sempre le idee. La vera sfida di un tempo in cui si può dire tutto, ma talvolta si rischia che tutto sia già stato detto, è proprio quella di ricercare una propria individualità e un proprio modo di far uso di un mezzo creativo. Certo, i tempi per prenderne piena padronanza sono lunghi e sostanzialmente non finiti, data la continua evoluzione degli strumenti stessi, ma ciò che conta davvero e secondo me trascende il limite della temporalità sono le idee.
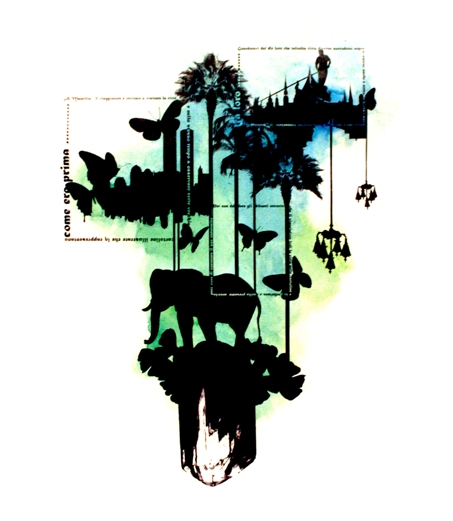
Matteo Menotto, “Maurilia”, 2011. Pittura digitale e acquerello su canvas, 70 x 50 cm.
Elvira D’Angelo: Le sue opere sono connaturate ad una imprescindibile dovizia tecnica. Il linguaggio che rende possibile e credile la loro esistenza trova un reale punto di forza nella padronanza degli strumenti digitali. Quanto pensa sia importante questo rispetto al valore dell’idea, concettualmente intesa? E può quest’ultima in qualche modo essere guidata dai mezzi linguistici?
Matteo Menotto: Sicuramente la tecnica, in qualsiasi campo delle arti, sia musica, pittura, grafica o scultura, richiede in un primo tempo un apprendimento minuzioso e devoto. Solo oltrepassando il gradino che l’acquisizione degli strumenti di base del nostro lavoro ci impone, possiamo guardare all’orizzonte infinito delle prospettive che essi ci offrono.
Premesso ciò, reputo che comunque l’idea abbia un valore a sé stante, a priori, almeno nella volontà di determinazione sul soggetto da comunicare e sul come renderlo. Di fatto credo che lo sviluppo tecnico e la consapevolezza dei risultati che si possono ottenere con una buona padronanza dei mezzi possano poi contribuire di pari passo alla definizione del lavoro finale o anche talvolta a suggerirne rese espressive prima non valutate.
Il rapporto tra arte e tecnica sicuramente è un tema universale nell’arte, d’altronde l’equilibrio visivo nel fronte del Partenone non sarebbe armonico senza gli studi sulla rastrematura dei rocchi delle colonne così come la cupola del Brunelleschi non sarebbe potuta esistere senza gli sviluppi meccanici sulla comprensione della partizione dei carichi e la stessa forma finale è a suo modo risultato dei limiti ingegneristici che imponevano una forma a sesto acuto e non semisferica.
Probabilmente la novità, forse lo slancio della nostra epoca, sta nel fatto che oggi siano sempre più spesso le tecnologie digitali a poter influenzare e offrire vie nuove al mondo dell’immagine e dell’arte applicata. Recentemente, ad esempio, ho visto alcune installazioni di videoarte di Pipilotti Rist dove molte delle suggestioni si ottenevano anche grazie agli effetti dei programmi di editing.
Elvira D’Angelo: Quali sono i suoi riferimenti culturali e linguistici?
Matteo Menotto: La letteratura è sicuramente una fonte inesauribile di spunti. Almeno per me lo è sempre stata. Vi è quel potere delle immagini che si vedono attraverso le righe, quel sogno di visioni nascoste tra segni e lettere e che disegnano un mondo. Leggo molto e tento di non pormi barriere di sorta. Prediligo la narrativa, ma sicuramente i racconti che lasciano maggiore spazio all’immaginazione sono quelli che danno forte spazio alle descrizioni, meglio se con un cotè misterioso o fantastico.
Cerco sempre il lato poetico, magari con un risvolto malinconico che si cela tra le righe.
Rileggo spesso O. Wilde, le poesie di T. S. Eliot e anche alcune fiabesche ma veritiere vicende di G. G. Marquez. Dai tempi del liceo poi ho un debole per i classici antichi: nel tradurre sia i testi teatrali che quelli con matrice filosofica ho sempre provato una sognante volontà di avvicinarmi ad un mondo perduto e fatto di una umanità più pura, ideale forse, più semplice nelle sue necessità ma talvolta più consapevole e profonda rispetto a noi.
Di fatto non sempre i miei autori preferiti sono poi quelli che riesco a rappresentare con più facilità, anzi. Nel caso de Le città invisibili il lavoro si è sedimentato nel tempo, dato che quello di Calvino fu uno dei primi testi che lessi alla facoltà di Architettura e mi colpì fin da subito per la forza evocativa che conteneva nelle sue descrizioni, così astratte e al tempo stesso così attuali e concrete nei possibili riferimenti. Così questa serie ha visto la luce molto dopo, quando l’università l’avevo già finita e oramai lavoravo da un po’.
Al contrario, per un altro ciclo che ho recentemente esposto a Milano, Fanciulle dall’inferno – una serie di ritratti delle figure femminili dell’Inferno dantesco, la fulminazione è stata istantanea e dalla definizione del tema all’esposizione delle opere è intercorso poco più di un mese.
Che siano le arti visive ad ispirarsi alla scrittura o alla musica o viceversa, in generale credo comunque possa essere sempre un buono stimolo cercare un collegamento trasversale tra le arti, d’altronde come scrive P. Valery l’estetica è una «grande ed anche irresistibile tentazione» che nasce dal fatto che «quasi tutti gli esseri che sentono vivamente le arti fanno un po’ più che sentirle; non possono sfuggire al bisogno di approfondire la loro gioia»[v].
Per l’esposizione sulle Città invisibili poi è stata provvida la circostanza di allestire la mostra presso la sala espositiva della Biblioteca Civica di Pordenone, un luogo per sua natura già correlato alla letteratura e sicuramente, in periodo più recente, connotatosi come un epicentro culturale anche all’interno della vita urbana.
Elvira D’Angelo: Pensa che in Italia le istituzioni educative svolgano un ruolo soddisfacente nella formazione di giovani che vogliano intraprendere un cammino creativo nel settore della new media art, e che consentano loro di confrontarsi con gli artisti di altri Paesi in cui vi è un’attenzione nei confronti della cultura digitale più consolidata?

Matteo Menotto, “Despina”, 2011. Pittura digitale e acquerello su canvas, 70 x 50 cm.
Matteo Menotto: Penso che sia importante viaggiare per raccogliere stimoli, ampliare gli orizzonti e confrontarsi con il mondo, ma credo anche che talvolta abbia valore, per ciascun viaggiatore, tornare arricchito delle proprie esperienze e con la volontà di “svuotare a casa” il bagaglio di questo lungo peregrinare.
Spesso vi è un gran dire circa il valore dell’istruzione all’estero rispetto alla formazione che c’è in Italia. Personalmente mi sono laureato a Venezia e specializzato a Milano, ma ho trascorso un periodo di studi a Londra e dopo la laurea ho lavorato per un anno e mezzo a Berlino. Credo che tutti questi passaggi mi abbiano dato molto e forse ho capito che non vi è un meglio ed un peggio nella gestione della formazione, anche nell’ambito creativo e delle arti visive, semplicemente vi è un differente approccio che determina anche la focalizzazione dell’attenzione su differenti aspetti della creatività stessa.
In Italia, ad esempio, l’attenzione per la storia e per la comprensione delle nostre radici è molto forte. Spesso, forse troppo, la mentalità più diffusa presso alcune istituzioni accademiche predilige la comprensione analitica del passato alla proiezione di questo nel futuro. Questo non penso sia un male in termini assoluti ma oggettivamente temo lo possa diventare nel suo essere un punto di vista univoco. Altrove in Europa il clima è diverso.
Facendo riferimento a Londra e Berlino, due realtà che ho vissuto in prima persona, me ne sono reso conto direttamente. A Londra l’attenzione per i media è altissima, la città stessa ti educa all’essere sempre “updated” per l’infinità degli stimoli che offre e per la velocità a cui li presenta. Berlino è una città possibilista, proprio come approccio culturale, nel senso che il contesto, anche grazie a politiche con una forte sensibilità sociale, stimola ciascuno ad una analisi introspettiva per trovare un proprio modus vivendi. A suo modo è una realtà in cui si intersecano infiniti mondi possibili e in cui l’omologazione viene meno. La città tuttavia sta cambiando molto e forse questi sono ancora i risvolti della totale libertà degli anni ‘90 che ad ora hanno, rispetto al resto della Germani, anche alcuni risvolti negativi.
Il bello del nostro tempo, a mio parere, è che comunque possiamo crescere confrontandoci e lasciandoci contaminare da tutti questi mondi senza chiuderci né intellettualmente né in termini di frontiere geografiche. A chi inizia gli studi adesso consiglierei di non fermarsi, di scegliere una percorso di riferimento come punto di partenza e poi di muoversi il più possibile cercando di cogliere le diverse sfaccettature che di quella stessa disciplina vengono trattate in diversi contesti. Io mi sono mosso sempre molto, con una strana inquietudine malcelata nel non sentirmi mai arrivato e infine ho capito che anche questa poteva essere una ricchezza per fare una continua e costante ricerca. La staticità in fondo è delle cose morte e questa consapevolezza la devo a un amico.
Elvira D’Angelo: In quale modo le sue città invisibili, dai particolari e contorni così definiti, si relazionano con l’epoca storica che stiamo attraversando contrassegnata, invece, da contorni fluidi, così come la definisce il sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman?
Matteo Menotto: Premesso che personalmente credo che i contorni del mio lavoro abbiano una loro fluidità, almeno nel disperdersi un po’ sognante dei toni dell’acquerello, mi rendo certamente conto che nel nostro tempo sia molto difficile trovare immagini con valore universale o leggibili univocamente. Personalmente non lo cerco nemmeno e anzi reputo che la forza del nostro momento possa derivare proprio dalla comprensione che viviamo in un’epoca di “molte verità”. Spero che coloro che guardano ai miei lavori vi trovino una chiave interpretativa personale; le grafiche sono sì chiare nei contorni delle silhouette ma “fluide” nella possibilità di figurarne i contenuti. Allo stesso modo in questo ho trovato la forza del linguaggio di Calvino che, adoperando riferimenti appartenenti alle città reali, è riuscito a creare mondi immaginari, fortemente evocativi di molti riflessi del vivere contemporaneo, ma mai racchiusi nella gabbia di una definizione geografica concreta e anzi liberi di figurarvisi nell’immaginazione del lettore. Sebbene le immagini abbiano almeno a livello grafico una loro fermezza, penso comunque che questo non precluda la dinamicità del pensiero di Bauman ma anzi ne possa essere un risvolto nella volontà di non fermarsi alla linea dei contorni ma di cercarne, immaginarne contenuti che di volta in volta partono dalle sensazioni di chi guarda e spero eludano un sentimento di statica permanenza oggettiva.
Elvira D’Angelo
[i] Henri Focillon, Vita delle forme – Elogio della mano; edizioni Einaudi, Milano 1990.
[ii] Ibidem, pp. 71-2.
[iii] Ibidem, pg. 116.
[iv] Citato in Riemen, prologo a George Steiner, Una certa idea di Europa (The idea of Europe), X Nexus Lecture, traduzione di Oliviero Ponte di Pino, prefazione di Mario Vargas Llosa, prologo di Rob Riemen, Garzanti Milano, 2006. Pg. 23; cfr. Giovanni di Salisbury, Metalogicon, edidit J. B. Hall ; auxiliata K. S. B. Keats-Rohan, Brepols, Turnholti 1991.
[v] P.Valéry, Introduction à la méthode de Leonard, Paris, Gallimard 1962. Pg. 102. Anche il «vicepresidente» M. Ravel è, come Valery, convinto sostenitore del primato del mestiere sull’ispirazione. Sulla sua concezione dell’opera «combinazione» si veda V. Jankélèvitch, Ravel, Paris, Seuil 1956.
:: ::
In homepage: Matteo Menotto, Maurilia, particolare.
Per approfondimenti sull’autore www.matteomenotto.com
Tag:Fotografia, Pittura Digitale




SCHEDE